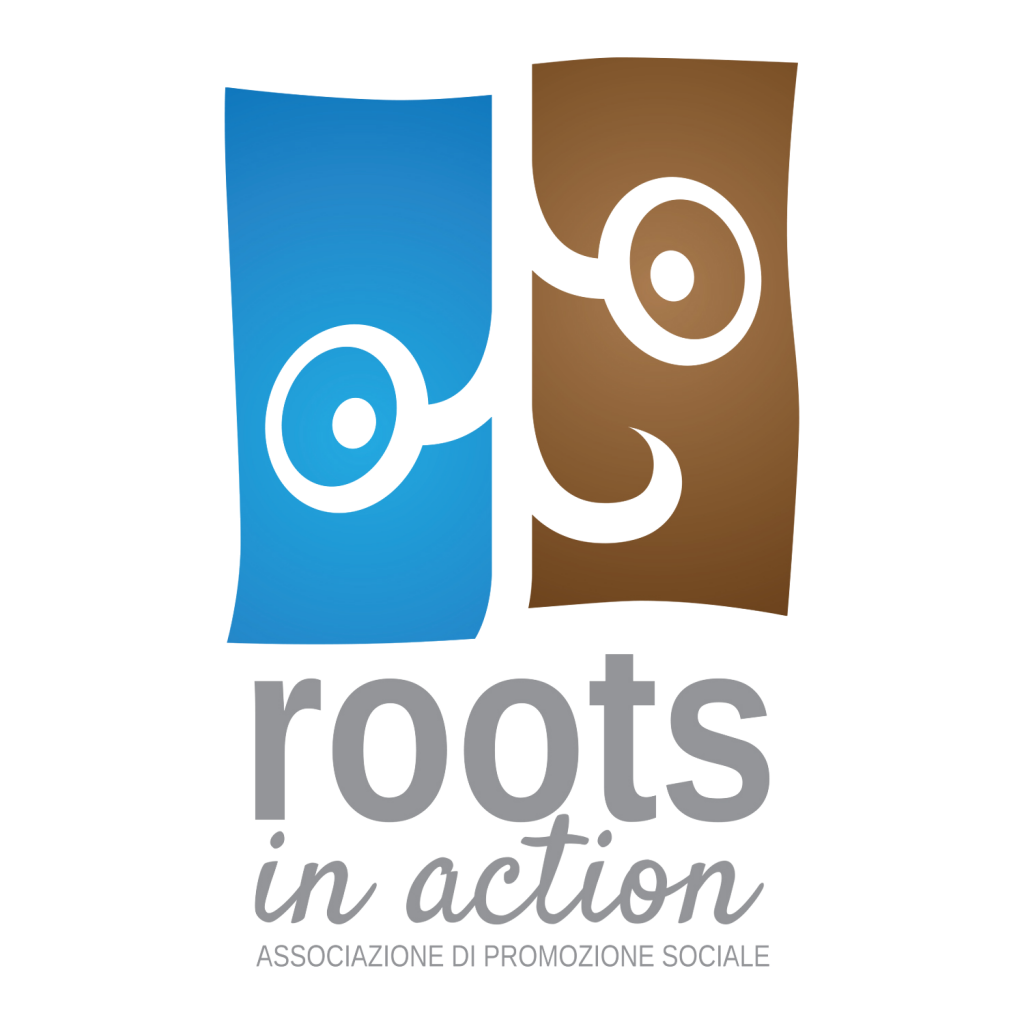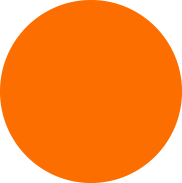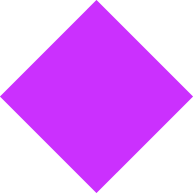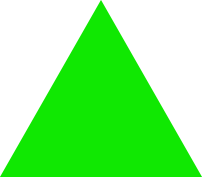Dislocate in diversi quartieri di Acerra, le “cantine” nascevano come piccoli esercizi dove era possibile bere e mangiare in compagnia. Note solitamente con il nome del gestore, restano nella memoria degli acerrani come luoghi di aggregazione ma anche come attività che hanno consentito di tramandare le tradizioni culinarie locali. Tra le tante: O’ Piuccio (sotto o’ suppuort), Scarpasciovete (reta a’ Tappia), Masillo, ‘O Cauciaiuolo, ‘O Ciacion, ‘A Eilla (ngoppo o puntciullo), ‘O Muzzon (in via Filomarini), ‘A cantina ‘e Totonn ‘e Carmnella (al Corso Garibaldi), zia Chiarina quatt’ova (in via De Gasperi) fino a Zi Matalena, ubicata nella zona del bosco, dove si fermavano i cacciatori per bere un bicchiere di vino o gustare prelibate pietanze.
Una delle cantine storiche e più care alla cittadinanza è “Addo Liborio”, una trattoria a conduzione familiare: dalla cucina al tavolo. L’attività, iniziata nel 1800 con Mugnolo Liborio, è stata continuata nel corso degli anni, dagli eredi, fino ad Angelo Raffaele (classe 1921) ed Armando Benito (classe 1924), che hanno lavorato fino al 1994, anno in cui è cessata l’attività. Venivano serviti piatti tipici della cucina napoletana ed acerrana: pasta e fagioli, zuffritto ‘e porco, stocco a ccassuola, fegatielle’ e porco, ‘friarielli, il tutto accompagnato dal vino di Solopaca. Il vino, sfuso, era prodotto dai fratelli Liborio, che avevano un grande torchio, capace di contenere 4-5 quintali di uva, che era pigiata dai ragazzi del portone. La vinaccia veniva trasportata a Pomigliano D’Arco, in una fabbrica, ed utilizzata per l’alcool. Così, racconta, oggi Capone Vincenzo, ragazzo del portone. La trattoria Liborio è citata anche in un articolo: “Chi fa le spese?”, del Monitore Acerrano del 21 luglio 1889. Un menù con le pietanze di Liborio e della pasticceria napoletana Caflisch, era una leccornia. La cucina era così buona e genuina, che girava il motto: ‘a gente cu’e stentine nbraccio va a mangià addò Liborio (tratto dal volume “La nostra identità nella scuola. Acerra 1861-1960” di Antonio Santoro, p.178-179)